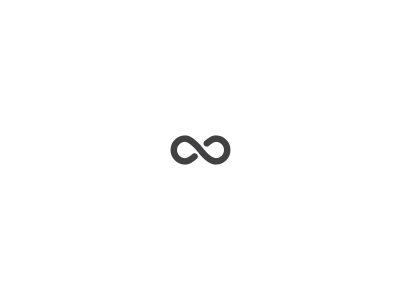Il nome deriva dal latino advocatus, participio passato di advocare, che significa “chiamare presso”, nel latino imperiale “chiamare a difesa”, e con utilizzo assoluto “assumere un avvocato”.
La professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che aveva in campo politico e molti celebri personaggi, come Quinto Ortensio Ortalo e Marco Tullio Cicerone, si distinsero nelle aule dei tribunali. La lex Cincia del 204 a.C. si occupò delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessun avvocato potesse ricevere doni prima di trattare una causa, forse con lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi diventasse eccessivo per i ceti più poveri. Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatusconsultus e venne introdotta una sanzione, per l’avvocato, pari a quattro volte la somma ricevuta in dono.
La legge fu modificata sotto Claudio, introducendo l’autorizzazione, per l’avvocato, a ricevere 10.000 sesterzi. Se si superava questa somma, l’avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum).
Ai tempi di Traiano venne stabilito che la somma potesse essere pagata alla fine della causa.
Oltre l’advocatus, econdo il diritto romano, i soggetti dell’ordine forense erano:
Il giureconsulto, Iuriconsultus (colui che è stato consultato in materia di diritto) era l’esperto del diritto, il giurista, ma che non teneva le “orazioni”, in altre parole non si recava in udienza. Era il soggetto dal quale si recavano le parti, il giurista diceva questa frase: “Narrami il fatto e ti darò il diritto” (Da mihi factum dabo tibi ius). Godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi, le soluzioni da loro date ai quesiti che venivano proposti erano considerate fonte di diritto .
Ancora oggi con il termine “giureconsulti” o “giuristi” si identificano gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare in modo principale i professori universitari delle Facoltà universitarie di giurisprudenza.
I più famosi nella Roma antica furono Paolo, Gaio, Modestino, Papiniano ed Eneo Domizio Ulpiano.
L’oratore, invece, era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l’oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l’oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.
La differenza appena descritta, tra oratore e giureconsulto, in qualche modo, la riscontriamo attualmente negli Stati Uniti, dove solitamente i legali si dividono tra coloro che vanno in udienza e si occupano principalmente dell’aspetto processuale e coloro che si occupano principalmente dello studio della causa e delle relazioni con i clienti.