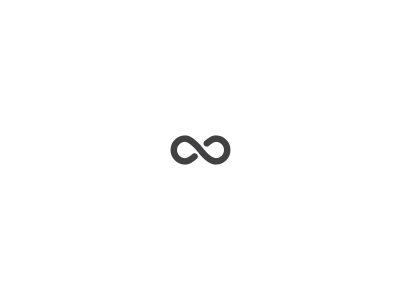Quando si parla di forme di compartecipazione nel reato, si utilizza un’espressione volutamente generica, capace di affasciare una serie di ipotesi spesso notevolmente diverse tra loro.
Ciò in quanto il nostro ordinamento conosce una serie molteplice di ipotesi di partecipazione nel reato che variano a seconda dei gradi, delle intensità di partecipazione e interconnessione delle condotte.
Si noti che il fenomeno della compartecipazione nel reato mette in evidenza come il legislatore considera il concorrere nel reato, cioè se in maniera uguale, diversa o più grave rispetto alla condotta monosoggettiva.
Allo stesso modo, da come il legislatore considera i reati associativi e a seconda dell’impostazione che di questi viene fornita, dimostra il modo in cui intende i principi di offensività, tipicità, tassatività e determinatezza nel diritto penale.
Infatti, le forme di compartecipazione nel reato presentano un comune denominatore in quanto sono tutte espressione del principio di offensività.
La norma di riferimento è l’art. 110 c.p., posta in apertura del Capo III, dedicato al concorso di persone nel reato.
Questo Capo si compone di dieci articoli che dettano una disciplina puntigliosa, sebbene non esaustiva, del concorso di persone nel reato.
In particolare, l’art. 110 c.p. stabilisce che: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni seguenti.”
Il successivo articolo, a tal proposito, prevede la disciplina applicabile nel caso in cui venga determinato alla commissione di un reato una persona non imputabile o non punibile.
Negli artt. 112 e 114 c.p. sono previste, rispettivamente, le circostanze attenuanti e aggravanti; mentre gli artt. 118 e 119 c.p. dettano i criteri per la valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, nonché delle circostanze di esclusione della pena.
Gli artt. 113, 116 e 117 c.p., invece, disciplinano figure peculiari di concorso di persone nel reato, in particolare la cooperazione colposa, il concorso anomalo e il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.
Infine l’art 115 c.p., che può considerarsi l’esempio del principio di offensività nel codice penale, stabilisce che il semplice accordo criminoso, la semplice istigazione a delinquere, non seguiti dalla commissione di un reato, danno vita a condotte non punibili ma, in quanto socialmente pericolose, possono dar luogo all’applicazione di misure di sicurezza.
Tuttavia, per trattare degli accordi criminosi, è necessario preventivamente conoscere i vari gradi di criminalizzazione che il legislatore immagina con riguardo alle diverse forme di compartecipazione criminosa.
In base a una scala progressiva di organizzazione criminosa il legislatore prende in esame: il concorso di persone, il gruppo organizzato (ma ai soli fini della transnazionalità) ed infine l’associazione per delinquere.
È bene premettere fin d’ora che le peculiari figure della cooperazione colposa, concorso anomalo e mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, nonché la connivenza non punibile si collocano fuori da questa scala.
La cooperazione colposa, disciplinata dall’art. 113 c.p., condivide con l’art. 110 c.p. sia la funzione incriminatrice estensiva, sia la funzione di carattere disciplinatorio.
La caratteristica di questo istituto risiede nel fatto che il legislatore interviene punendo i soggetti che abbiano violato una regola cautelare o abbiano cagionato una lesione al bene giuridico involontariamente.
Pertanto, il discrimen tra la cooperazione colposa, il concorso di persone e il concorso di cause indipendenti di cui all’art. 41 c.p. è costituito dall’adesione psicologica alla condotta altrui.
In particolare, nel primo caso vi è la coscienza e la volontà di concorrere nel reato; nel secondo caso non vi è volontà di concorrere, ma il soggetto è a conoscenza del fatto illecito altrui (in quanto contrario a diligenza, prudenza, perizia o a leggi, ordini, etc.); nell’ultimo caso, il soggetto non ha alcuna coscienza della condotta altrui.
Il legislatore, inoltre, sempre in omaggio al principio di offensività e a dimostrazione della pregnante preoccupazione che ha nei confronti dei fenomeni di compartecipazione, oltre a prevedere la fattispecie plurisoggettiva eventuale, ex art. 110 c.p., all’art. 116 c.p. immagina anche un concorso anomalo.
Questa norma prevede la possibilità che un soggetto possa essere chiamato a rispondere per il reato diverso commesso dal compartecipe, che non ha voluto.
Tale norma è sempre stata oggetto di varie critiche, poiché contraria al principio di colpevolezza, nonché al principio di offensività.
L’agente infatti viene punito per un fatto che non ha voluto: dunque si punisce a titolo di dolo un comportamento colposo.
La Corte di Cassazione in due occasioni (febbraio e marzo 2014) ha evidenziato che per far scattare l’applicabilità dell’art. 116 c.p. è fondamentale una valutazione sulla prevedibilità in concreto del reato commesso dal concorrente, diverso da quello da lui voluto.
La Corte, quindi, evidenzia espressamente che non può essere ammesso un tale automatismo, ma occorre dimostrare che, in base alle circostanze del caso concreto, il reato diverso era concretamente prevedibile.
Il mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti, disciplinato all’art. 117 c.p., stabilisce dapprima la regola generale della comunicabilità tra i concorrenti del mutamento del titolo di reato, qualora questo derivi dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, ovvero dai rapporti fra il colpevole e l’offeso. Infine, attribuisce al giudice la facoltà di diminuire la pena a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Sempre al di fuori della progressione criminosa di cui si è detto, si pone la connivenza non punibile.
La giurisprudenza si è occupata della rilevanza penale del comportamento meramente passivo di un soggetto, segnando la linea di demarcazione tra l’art. 110 c.p. e la connivenza non punibile.
Se normalmente l’inerzia di un soggetto o la mera presenza dello stesso sul luogo di un delitto possono sembrare non punibili, tuttavia la responsabilità non può considerarsi automaticamente esclusa.
In particolare essa non è esclusa in tutte quelle ipotesi in cui presenta un connotato agevolatorio poiché si innesta in un programma criminoso ideato e approvato. Pensiamo ad esempio al classico caso del palo.
Proprio in relazione all’art. 609-octies c.p. che disciplina il reato di violenza sessuale di gruppo, si è posto il problema di capire se può applicarsi l’art. 110 c.p. al fine di estendere la punibilità a coloro che, sebbene non pongano in essere alcuna condotta tipica, partecipano o agevolano in qualunque modo, anche con un mero comportamento inerte, la consumazione del reato.
La Corte, per risolvere la questione, ha dato importanza ad un criterio “spaziale” evidenziando come, in caso di presenza simultanea di più soggetti sul luogo della violenza sessuale, deve ritenersi applicabile l’art. 609-octies c.p., differentemente, in caso di mancanza di tale requisito, si può applicare l’art. 110 c.p. al fine di estendere la tipicità della norma a coloro che non pongono in essere alcuna condotta tipica.
Forme di partecipazione criminosa:
Tornando ad analizzare la scala di progressione criminosa, la prima e più elementare forma di partecipazione è rappresentata dal concorso di persone.
Il compartecipare nel reato è sempre stato considerato più grave e più pericoloso del delinquere singolarmente. Anche il diritto romano puniva sia l’autore che il partecipe del reato, distinguendo l’architectus del delictum, dai partecipi e dai consortes del delitto. Non solo quindi conosceva il fenomeno compartecipativo, ma già immaginava una diversità di ruoli all’interno di esso.
L’art. 110 c.p. ha, al pari degli artt. 56 – 40, II co. – 59 – 113 c.p., una funzione estensiva della tipicità in quanto si attribuisce rilevanza penale a condotte normalmente atipiche, condotte che in assenza dell’art. 110 c.p. non sarebbero punibili. Il combinato disposto della norma in esame con la norma di parte speciale dà vita ad una fattispecie plurisoggettiva eventuale (del tutto autonoma) che normalmente si caratterizza per la ricorrenza dei seguenti requisiti: pluralità di agenti; commissione di un reato nella forma almeno tentata; contributo dei concorrenti.
L’attenzione è incentrata maggiormente sul partecipe del reato che non sull’autore del fatto tipico, in quanto, normalmente, quest’ultimo può già rispondere del reato monosoggettivo. La funzione di estensione, quindi, riguarda il partecipe.
Ciò emerge anche da come la giurisprudenza intende l’elemento soggettivo e il nesso di causalità nel concorso di persone.
In particolare, il partecipe risponde del reato non solo se lo ha materialmente o moralmente causato, ma anche nel caso in cui abbia fornito un contributo agevolatore.
In riferimento al nesso di causalità, il contributo penalmente rilevante è quello che ha fornito un apprezzabile supporto per la realizzazione della condotta finale e per la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, siamo in presenza del cd. dolo di concorso che, ormai pacificamente, non deve necessariamente essere identico in tutti i concorrenti ma deve ricoprire tutto il fatto tipico.
Sul secondo gradino della scala criminosa si pone il gruppo criminale organizzato, richiamato dall’art. 4, legge 146/2006 in tema di transnazionalità.
Ed infatti, è proprio ai fini della transnazionalità che risulta necessario distinguere il concorso di persone dal gruppo organizzato.
Quest’ultimo può quindi essere definito come una figura che ha una sua ragione di esistere solo in relazione all’applicabilità delle norme sulla transnazionalità.
La legge sulla transnazionalità è di ratifica della Convenzione di Palermo, una convenzione internazionale che aveva come obiettivo quello di creare una serie di regole in relazione ai fenomeni transnazionali che, quindi, riguardano più Stati.
Per tale motivo si era presentata la necessità di trovare una nozione che fosse comune e si adattasse a Stati diversi. Di qui quella di gruppo criminale organizzato, che costituisce una mediazione tra opposti ordinamenti caratterizzati da principi differenti.
La differenza tra gruppo organizzato e concorso di persone, come ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risiede nella diversa graduazione dell’organizzazione.
Il primo ha una struttura più sofisticata rispetto al concorso di persone ed è destinato a durare nel tempo. Il concorso di persone, invece, è un fenomeno di compartecipazione tesa al perseguimento di uno o più reati tutti determinati: si tratta di un’attività episodica (anche se può essere reiterata) con struttura normalmente improvvisata.
Il gruppo criminale organizzato ha una struttura differente anche rispetto a quella dei reati associativi che richiedono una costruzione più professionale, una maggiore organizzazione, con una ripartizione di ruoli.
I reati associativi rappresentano il terzo ed ultimo gradino della progressione criminale delineata dalla giurisprudenza in relazione alle forme di compartecipazione.
I reati associativi sono sparsi un po’ in tutto il codice penale e nelle leggi complementari e costituiscono una deroga all’art. 115 c.p. che prevede l’irrilevanza dell’accordo non seguito dalla commissione del reato.
Gli accordi criminosi di carattere associativo possono essere suddivisi in due categorie, in base ai campi applicativi:
- in relazione al fenomeno politico/istituzionale, in cui le associazioni perseguono programmi criminosi istituzionali (associazioni sovversive, terrorismo, etc.);
- in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, in cui le associazioni perseguono scopi leciti ma con mezzi vietati (associazione mafiosa, banda armata, etc.).
Un primo dato comune alle ipotesi di associazione per delinquere è che, normalmente, si pongono in conflitto coi principi di tassatività e/o offensività.
La banda armata, ad esempio, prevista dall’art. 306 c.p. – da sempre sospettato di incostituzionalità- si pone in contrasto con il principio di tassatività, poiché il legislatore non ne definisce la nozione.
Si pongono in potenziale conflitto con il principio di offensività, invece, i reati associativi di cospirazione politica, le associazioni sovversive, l’associazione per delinquere, ma soprattutto l’istigazione per delinquere. Consapevole del potenziale conflitto la giurisprudenza, nonostante qualche perplessità iniziale, ha costruito i reati di associazione per delinquere come reati di pericolo concreto. E proprio la natura di reati di pericolo concreto rappresenta il secondo dato comune a tutti i reati di associazione che, in tal modo, svolgono una funzione di tutela anticipata nel rispetto del principio di offensività. Il legislatore ritiene che reprimendo l’associazione in sé, si possa prevenire e rimuovere il pericolo di commissione degli obiettivi finali dell’associazione, cioè dei reati-fine.
FOCUS: Associazione per delinquere, associazione di stampo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso
Nelle ipotesi contemplate negli artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p., ci troviamo di fronte a reati posti a tutela dell’ordine pubblico e, pertanto, si pone innanzitutto il problema di definire cosa si intenda con tale concetto e quali sono le associazioni che si pone contro di esso.
L’ordine pubblico è un concetto giuridico trattato in vari ordinamenti che, ciononostante, resta vago e dai confini troppo labili e incerti. L’opera dell’interprete ha portato, negli anni, a distinguere tra un ordine pubblico materiale (o empirico) e ordine pubblico in senso ideale (o normativo).
L’ordine pubblico in senso materiale si rifà sostanzialmente ad una condizione di pacifica convivenza, immune da disordine e da violenza (sinonimo di sicurezza collettiva).
L’ordine pubblico ideale o normativo evoca un’entità ideale costituita dal complesso di principi e dal complesso di istituzioni fondamentali da cui dipende la sopravvivenza dell’ordinamento. Questo modo di intendere l’ordine pubblico corrisponde, quindi, all’ordine pubblico costituito.
Nel diritto penale, chino sui principii di offensività, tipicità, tassatività e determinatezza è stato accolto il concetto di ordine pubblico materiale. Tuttavia la Corte Costituzionale, in due occasioni, ha accolto una ricostruzione mediana: l’ordine pubblico nel diritto penale è sicuramente da intendere in senso materiale, ma in determinate ipotesi – ne è esempio emblematico l’art. 416 bis c.p.- deve essere inteso anche in senso ideale, quale ordine pubblico precostituito. In particolare, tale lettura è necessaria e doverosa quando queste associazioni abbiano una tale forza criminosa da poter sconvolgere le istituzioni fondamentali (ad es. trattativa Stato – mafia).
Tra tutti i reati contro l’ordine pubblico, l’associazione per delinquere è quello che pone maggiori perplessità in relazione al rispetto del principio di tassatività.
L’art. 416 c.p. fa il suo esordio nel 1930 con l’emanazione del Codice Rocco, dove il legislatore ha voluto introdurre una figura criminosa che fosse idonea a fronteggiare le più svariate forme di manifestazione della criminalità organizzata. Questo obiettivo il legislatore lo sconta però con un deficit di tipicità. Come spesso accade nel diritto penale, al deficit di tipicità della fattispecie è costretta a porvi rimedio la giurisprudenza con l’opera laboriosa di interpretazione. La giurisprudenza, negli anni, ha delineato i requisiti essenziali dell’associazione per delinquere: vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente; struttura organizzativa non rudimentale; indeterminatezza del programma criminoso; dolo specifico di concorso.
I complementari requisiti che differenziano l’associazione (art. 416 c.p.) dal concorso di persone (art. 110 c.p.) sono la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso. Quest’ultimo requisito, ripreso dalla giurisprudenza, venne elaborato da Manassero in un testo nel 1914 dal titolo “il delitto collettivo e la teoria del concorso”, dunque l’indeterminatezza del programma criminoso ha preceduto anche il legislatore del 1930.
Il dubbio oggi riguarda un po’ l’organizzazione richiesta. La struttura organizzativa, inoltre, è utile a distinguere l’associazione per delinquere sia dal concorso di persone che dal gruppo criminale organizzato e quindi definirne la portata è quanto mai necessario.
Secondo una prima ricostruzione, poiché l’art. 416 c.p. non dispone nulla a tal proposito, basta qualunque organizzazione, anche rudimentale.
La ricostruzione oggi prevalente, invece, richiede un’organizzazione più articolata, funzionale al perseguimento di una serie molteplice di delitti non determinati. Per fare ciò non basta una mera organizzazione rudimentale ma occorre una struttura molto più organizzata. Aderendo a questa ricostruzione – come del resto hanno fatto le Sezioni Unite del 2013 in tema di transnazionalità- si segna una meravigliosa distinzione: associazione per delinquere, gruppo criminale organizzato e concorso di persone.
Tale distinzione, astrattamente chiara, pone però una serie di perplessità di ordine probatorio poiché in concreto non è così agevole distinguere le varie categorie.
La giurisprudenza si è anche interrogata sulla possibilità di commettere il delitto di associazione per delinquere utilizzando strutture lecite. Sul punto ci sono state due ricostruzioni.
La tesi negazionista, secondo cui consorteria criminosa e attività lecita non possono mai convivere in quanto tra loro vi è una logica incompatibilità.
Altra impostazione ha invece ritenuto che rientra nel penalmente rilevante quell’attività che, seppur lecita, risulti anche in parte funzionalmente tesa al perseguimento di un indeterminato numero di delitti. In tali casi quindi, non vi sarebbero ragioni logiche per escluderne la configurabilità.
L’art. 416-bis c.p. è stato introdotto dal legislatore per colmare la lacuna dell’art. 416 c.p., che non era in grado di cogliere le peculiarità dei fenomeni mafiosi diffusi prevalentemente nei territori siciliani e calabresi. Siamo di fronte ad una norma che disciplina certamente un reato plurioffensivo, in quanto non va a ledere il solo ordine pubblico, ma anche la libertà di mercato, la libertà di iniziativa economica, le istituzioni pubbliche, nonché le competizioni elettorali.
La norma, inoltre, è sia il frutto di un’evoluzione legislativa, sia di un’elaborazione giurisprudenziale.
Infatti, la legge del 1982, che ha novellato il codice introducendo la norma in esame, si pone all’esito di un percorso legislativo che già aveva introdotto nel linguaggio comune le espressioni “mafie” e “mafia”.
Il riferimento è alla legge n. 1423 del 1956, che ha introdotto le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità e alla legge n. 575 del 1965, che ha previsto disposizioni contro la mafia.
Non è un caso che siano gli anni in cui sono entrate in vigore queste norme siano il 1956 e 1965, poiché è proprio negli anni ’50 e ’60 che il fenomeno mafioso incomincia a diffondersi con prepotenza.
La prima sentenza della Corte di Cassazione che parla di mafia nel nostro sistema risale al 22 giugno del 1965, dunque molto prima dell’introduzione dell’art. 416 bis c.p. nel codice penale.
In questa pronuncia la Cassazione, per la prima volta, fa un velato riferimento al fenomeno mafioso. La Corte, in particolare, occupandosi dell’art. 610 c.p. ha ritenuto che, per la sua consumazione, fosse idonea ogni forma di minaccia, implicita o esplicita, diretta o indiretta, reale o simbolica, purché percepita dal soggetto passivo. La sentenza ha assunto notevole importanza perché ha evidenziato che, anche in assenza di parole e gesti espliciti e di atti di intimidazione eclatanti, il semplice atteggiamento del soggetto attivo può integrare una minaccia punibile, quando assuma carattere di intimidazione in rapporto all’ambiente. Siamo in un ambiente in cui le prepotenze, le vessazioni sono elevate a regola di vita, in un ambiente in cui anche l’offerta di protezione fatta da un soggetto all’altro soggetto può assumere le sembianze di una violenza o una minaccia, punibile ex art. 610 c.p.
In definitiva, la sentenza ha avuto il merito di ampliare l’ambito applicativo dell’art. 610 c.p. inglobandovi comportamenti non palesemente minacciosi, ma che potevano divenire tali in base all’ambiente.
Quattro anni dopo, il 29 ottobre 1969, la Cassazione si è pronunciata nuovamente, ma questa volta lo ha fatto direttamente in relazione al reato di associazione mafiosa evidenziando che tale concetto – pur non essendo definito da una norma – aveva assunto nel linguaggio comune un significato inequivoco e limiti ben precisi, richiamando fenomeni di grave antisocialità, ben individuati sotto il profilo sociologico e sotto il profilo territoriale.
L’art. 416-bis c.p. è una figura tipica del nostro sistema, sconosciuta al di fuori dell’Italia. Essa rappresenta una speciesdell’associazione a delinquere prevista all’art. 416 c.p. ma non ha, almeno per larga parte, i difetti di tipicità che caratterizzano quest’ultima. Il motivo è presto detto: la ratio che ha ispirato le due norme è assolutamente differente. L’art. 416 c.p. nasce da un’esigenza di creare un contenitore per rendere penalmente rilevante qualunque fenomeno di criminalità organizzata e, come detto, il legislatore sconta questo obiettivo con un deficit di tipicità. L’art. 416-bis c.p., invece, essendo frutto di un intervento mirato, ha una ratio differente: vuole colpire quel fenomeno tipico e specifico dell’associazione mafiosa, e ne delinea i requisiti particolari.
Con riguardo ai requisiti strutturali il legislatore ha utilizzato due criteri per distinguere l’associazione per delinquere semplice da quella di stampo mafioso: uno fa leva sui mezzi utilizzati, l’altro sui fini perseguiti.
Quanto al primo criterio si richiede una forza intimidatrice capace di determinare una condizione di assoggettamento e di omertà. La giurisprudenza, per altro, ha specificato che non è necessaria la realizzazione di una minaccia o una violenza, essendo sufficiente una condotta intimidatoria, anche implicita, se posta in essere all’interno di un alone diffuso, penetrante di presenza intimidatoria. Quindi, anche in assenza di violenza o minaccia, è possibile immaginare una forza intimidatrice. Tuttavia, occorre anche che questa capacità intimidatoria sia causalmente collegata ad una condizione di assoggettamento o di omertà, pertanto, è necessaria una situazione di sottomissione e di sudditanza psicologica.
Il secondo criterio, riguarda invece i fini, che nell’associazione per delinquere di stampo mafioso sono molto più ampi.
Il legislatore, con la legge n. 125 del 2008 ha modificato la rubrica dell’art. 416-bis c.p., facendo riferimento alle associazioni di tipo mafioso anche straniere ed ha introdotto un ottavo comma:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”
La ratio di questa novella è molto simile alla ratio ispiratrice dell’art. 416 c.p., cioè a dire: il legislatore vuole creare un meccanismo capace di abbracciare qualunque tipo di associazione che abbia i connotati descritti dal primo comma. In particolare, il problema riguarda le altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere. Secondo molti, a seguito dell’introduzione di questo comma, anche tale norma sconterebbe un difetto di tipicità. Secondo altri è un comma inutile, poiché tutto quello che vuole realizzare già è realizzato dal primo comma.
In sostanza l’associazione di tipo mafioso è un modo per indicare un consorzio criminoso connotato da un’alta organizzazione, una ripartizione di ruoli, nonché la capacità di influire nella vita pubblica di un paese.
Tuttavia, le maggiori perplessità applicative di tale norma si sono poste in relazione alla definizione della figura non disciplinata – o meglio, non definita – del concorso esterno in associazione mafiosa.
Anche il concorso esterno in associazione per delinquere viene forgiato negli anni ’70 – ’80, ma in relazione al terrorismo (reati politici) e non alla associazione mafiosa. Nello stesso arco temporale, però, si diffonde prepotentemente anche il fenomeno mafioso e così le coordinate ermeneutiche tracciate molto timidamente sul concorso esterno vengono trasportate all’associazione mafiosa.
L’interprete, una volta ritenuta l’ammissibilità di tale istituto, si è interrogato sulla struttura sostanziale del concorso esterno in associazione mafiosa.
Coloro che inizialmente dubitavano sull’ammissibilità del concorso eventuale nei reati a concorso necessario, sostenevano che la funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p. non potesse riguardare anche i reati a concorso necessario.
Si riteneva in particolare che il legislatore, punendo determinati soggetti a titolo di concorso, avesse già immaginato i reati a forma pluripartecipata nella loro massima estensione.
Tale impostazione, però, è stata ben presto superata per due ragioni: una di ordine letterale, l’altra ideologica.
Quanto al primo argomento, letterale, si è sottolineata la possibilità di applicare l’art. 110 c.p. a tutte le norme di parte speciale, non essendoci alcuna ragione per vietarne l’applicazione ai reati associativi e, in particolare, all’art. 416-bis c.p.
A sostegno di tale interpretazione si citava, in senso positivo ed implicito, l’art. 418 c.p. (assistenza agli associati), in base al quale “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione fino a due anni.” Questa norma, quindi, ad avviso di questa interpretazione, costituisce la prova positiva, letterale, dell’ammissibilità del concorso esterno nell’associazione mafiosa.
Sul piano ideologico, invece, non si riteneva possibile lasciare fuori dal penalmente rilevante le condotte di un soggetto che, sebbene esterno all’associazione, contribuisse alla vita della stessa.
Dalla sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite del 5 ottobre 1994 (Demitry), nessuno dubita più sull’ammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa.
Il problema, quindi, si è spostato dall’ammissibilità del fenomeno alla delineazione degli elementi strutturali e ci si domanda quando debba ritenersi sussistente il concorso esterno in associazione mafiosa.
La sentenza del 1994 dettò dei criteri, in parte oggi superati. Il merito di questa sentenza è quello di aver evidenziato che le condotte del partecipe e quelle dell’extraneus non sono condotte tra loro sovrapponibili, bensì sono distinte. In particolare, si è offerto un criterio certo per distinguere la figura del partecipe – che agisce nella fisiologia, nella vita corrente, nella vita quotidiana dell’associazione- da quella del concorrente esterno, individuata nel soggetto che “non vuole far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a far parte”, al quale però la stessa si rivolge per colmare temporanei vuoti, in un momento in cui entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica che può essere superata solo, o prevalentemente, con il contributo temporaneo del concorrente esterno. Quella dell’extraneus è, quindi, un’opera salvifica. Il dolo del concorrente esterno non deve essere necessariamente specifico, ma è sufficiente un dolo generico: coscienza e volontà di concorrere, avendo la percezione di quali siano o possano essere gli obiettivi generali dell’associazione, nonché dei mezzi con cui questi obiettivi vengono perseguiti.
Questa ricostruzione, però, attribuiva al concorso esterno un ambito applicativo molto ristretto.
Come spesso accade, ciò che nel 1994 era stato considerato una vittoria, nel 2005 viene visto come una sconfitta: ci si era resi conto che la lettura data era troppo restrittiva.
Comincia così una progressiva marcia di erosione del requisito della “fibrillazione della associazione”, nell’intento di ampliare l’ambito applicativo del concorso esterno.
Il primo timido colpo a questo requisito viene dato con la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 luglio 2005 n. 33748 (Mannino), che ha considerato non decisivo il requisito della fibrillazione per inquadrare la condotta del soggetto che, pur non entrando nell’associazione, partecipa alla funzionalità della struttura associativa.
Ciò anche in considerazione del fatto che per farlo non è necessario uno stato patologico essendo sufficiente uno stato fisiologico.
Il dolo dell’extraneus è un dolo diretto che deve investire sia il fatto tipico, sia il contributo causale teso tanto all’opera salvifica dell’associazione quanto alla sua conservazione o, addirittura, al suo rafforzamento. Il soggetto deve agire nella consapevolezza e con la volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.
In definitiva, rispetto alla sentenza Demitry, viene eliminato il requisito patologico; viene stabilito che il concorrente esterno deve agire con dolo diretto e non con dolo eventuale; che coscienza e volontà devono ricoprire il fatto tipico e il contributo causale; il contributo casuale deve essere teso alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione; vi deve essere, altresì, la consapevolezza di contribuire, almeno in parte, alla realizzazione del programma criminoso.
La Suprema Corte tornerà nuovamente sull’argomento con la sentenza del 17 Maggio 2012, n. 34979, soffermandosi sul dolo del concorrente esterno.
Dopo aver ribadito che il dolo del concorrente esterno deve avere ad oggetto tutti gli elementi essenziali della figura criminosa – sia del fatto tipico sia del contributo causale – stabilisce che l’agente deve avere anche la consapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con lo schema associativo. Il concorrente esterno, quindi, è un soggetto che interagisce con l’associazione ma che è sprovvisto dell’affectio societatis. In altre parole, deve essere consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione e si deve rendere compiutamente conto dell’efficacia causale del suo contributo.
Il percorso di definizione giurisprudenziale dell’istituto è stato arricchito da un ulteriore contributo della Corte di Cassazione che, con sentenza del 9 maggio 2014 n. 28225, ha espressamente evidenziato la possibile sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa anche in relazione ad attività del concorrente esterno di carattere pluriennale. E quindi, oggi, si riconosce il concorso esterno non solo con riguardo ad un episodio, ad un momento di fibrillazione, ma anche in seguito ad un’attività duratura che si è sviluppata per diversi anni. Ciò che conta non è l’aspetto formale (fisiologia o patologia), ma strutturale.
Sul piano probatorio, però, quando viene accertata la fibrillazione dell’associazione è molto più facile dimostrare la sussistenza del concorso esterno: il problema riguarda l’aspetto fisiologico.
Da ultimo, la Cassazione con sentenza del 18 giugno 2014 con sentenza n. 33885 definisce il concorrente esterno come quel soggetto che, sebbene non abbia l’affectio societatis, nondimeno fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a condizione che tale contributo esplichi un’effettiva rilevanza causale e si configuri come condizione necessaria per la conservazione o per il rafforzamento. La condotta, inoltre, deve tendere alla realizzazione sia pur parziale del programma criminoso.
Tali requisiti sono stati riconfermati dalla giurisprudenza successiva che, in particolare ha ribadito sia che l’extraneus deve offrire all’organismo mafioso una disponibilità protratta nel tempo (Cass. Pen., Sez. V, 14 giugno 2018, n. 45840), sia la necessità del dolo diretto ai fini della configurabilità del concorso esterno, da intendersi quale coscienza e volontà del rafforzamento del sodalizio tramite la realizzazione anche solo parziale del programma criminale (Cass. Pen., Sez. V, 11 giugno 2018, n. 35845).
Il concorrente esterno, quindi, è un soggetto che non fa mai parte dell’associazione mafiosa, ma spesso è collegato al mondo della politica. Per tale motivo è spesso difficile distinguere il concorso esterno (ex artt. 110 – 416-bis c.p.) dallo scambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter c.p.
La Legge 17 aprile 2014, n. 62 ha riformato l’art. 416-ter c.p. nell’ottica di fronteggiare con misure più incisive i fenomeni di Tangentopoli. Per comprenderne tutta l’essenza è necessario distinguere le due fasi storiche, quella antecedente e quella successiva alla legge 2014.
La norma vede la sua genesi nel Decreto Legge 8 Giugno 1992 n. 306 frutto della legislazione emergenziale di quel periodo, in risposta agli attentati di quegli anni: in particolare quello di Capaci, avvenuto qualche settimana prima.
Il vecchio disposto recitava:
“la pena stabilita dal primo comma dell’art 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio dell’erogazione di denaro”.
Aspetto fondamentale era che il promissario doveva essere ben consapevole del soggetto che aveva di fronte. Tuttavia, erano considerate prive di rilevanza penale le modalità di reperimento del consenso, poiché – si sosteneva – la potenzialità lesiva della condotta era data dalla mercificazione del libero consenso democratico.
Era una norma che rinviava al 416 bis c.p. e riguardava un aspetto dell’associazione mafiosa: procacciare voti e controllare la macchina pubblica. Ecco la confluenza e, quindi, la difficoltà di distinzione. Fin da subito, infatti, nacquero dubbi sulla differenza tra 416-ter e 416-bis c.p.
Tuttavia, il problema era solo dogmatico e classificatorio, infatti in un caso o nell’altro, si applicavano le stesse pene. Era questa la risposta che spesso si dava al quesito.
Con la legge n. 62/2014 si è tentato di leggere l’evoluzione di questo fenomeno e di ampliare l’ambito applicativo della norma, sia per quanto riguarda la condotta, che ora può consistere nella promessa o erogazione (non solo erogazione) di denaro o altre utilità (non solo denaro), sia in riferimento ai soggetti attivi, poiché si costruisce un reato necessariamente plurisoggettivo in cui si prevede la punibilità anche del promittente/affiliato.
L’art. 416-ter c.p., quindi, è ora un reato di pericolo, necessariamente plurisoggettivo e proprio.
Si deve precisare che le modifiche alla norma sono state apportate perché lo richiedeva la Comunità Europea. In particolare il Parlamento Europeo aveva espresso la necessità di sanzionare il voto di scambio attraverso la previsione non solo dell’erogazione di danaro, ma anche di ogni altra utilità. Perché i vantaggi che l’associazione si ripromette possono consistere non solo in denaro ma anche in altre utilità, e possono riguardare anche terze persone non direttamente coinvolte ed implicate nell’accordo illecito.
In particolare, uno degli aspetti molto dibattuti ha riguardato proprio il metodo mafioso.
Nei lavori preparatori si legge che “la necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso nel patto ex art. 416-ter c.p.è una probatio diabolica, perché il metodo mafioso non attiene alla struttura del reato di cui all’art. 416-ter che è un reato di pericolo. L’inserimento di questo aspetto rischia di vanificare la struttura del reato”.
La formulazione iniziale, infatti, prevedeva che
“Chiunque fuori delle previsioni di cui al 416 bis comma terzo, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, ottenga promessa di voti etc..”.
Non vi era alcun riferimento al metodo mafioso perché altrimenti si rischiava da un lato di ampliare l’ambito applicativo con riferimento alle altre utilità, dall’altro di restringerlo, con una probatio diabolica. Come si può leggere dal codice, questa proposta non è stata accolta.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che si è pronunciata sulle novità normative, con una sentenza del 28 Agosto 2014 n. 36382, evidenziando che la norma contiene una grande novità rispetto al passato. La novità è che il patto deve riguardare sì lo scambio voti–utilità, ma in questo scambio deve essere ben chiaro che il procacciamento dei voti avverrà con le modalità tipiche mafiose. Il metodo mafioso diventa, secondo questa giurisprudenza, requisito strutturale.
Diversamente, un altro filone giurisprudenziale ritiene che le vere novità apportate all’art. 416-ter c.p. siano due: l’estensione dell’ambito applicativo alle altre utilità e la punibilità del promittente. Non sarebbe una reale novità, invece, l’aver inserito espressamente come requisito strutturale anche la circostanza in base alla quale il patto deve far riferimento alle modalità mafiose per procacciare i voti. Si ritiene che questo fosse un requisito strutturale già prima della novella. Quindi la differenza non sarebbe in questo nuovo requisito strutturale, costituito dal metodo mafioso, ma è da rinvenire con riguardo agli altri due requisiti.
Inoltre, con la riforma, viene eliminato il rinvio, in punto sanzionatorio, all’art. 416-bis c.p.; la fattispecie inizia a guadagnare un’autonoma applicazione e, pertanto, si pone l’esigenza pratica di stabilire i confini delle due norme attigue.
In particolare, il punto oggi è capire che rapporti intercorrono tra gli artt. 416-ter, 416-bis e il concorso esterno. Essendo un reato a concorso necessario, è utile distinguere il promittente dal promissario.
Per il promittente la soluzione è più facile, in quanto si deve comprendere se può concorrere l’art. 416-bis c.p. con l’art. 416-ter c.p., facendo parte della associazione e non si pone la questione del concorso esterno. Sebbene secondo alcuni i due reati non possano concorrere, oggi l’orientamento maggioritario ammette pacificamente il concorso tra questi, posto che l’innovazione normativa sarebbe tesa a rendere un maggiore carico di lesività e a riconoscere una maggiore pericolosità a queste condotte. Quindi, se il soggetto è un associato e pone in essere anche le condotte previste dall’art. 416-ter c.p. risponderà per entrambi i reati.
Con riguardo, invece, al promissario si pongono una serie di problemi.
Certamente l’art. 416-bis c.p. e l’art. 416-ter c.p., dal punto di vista del promissario, non possono concorrere, perché il promissario normalmente non è un associato.
L’art. 416-ter c.p. viene definito come norma che realizza un’estensione della punibilità oltre il concorso esterno. Si immagina una gradazione ulteriore: partecipe/affiliato -> concorrente esterno-> contraente del patto di scambio politico mafioso. Siamo, quindi, di fronte a una norma che ha l’obiettivo di estendere la tipicità con riguardo a fattispecie altrimenti non punibili, perché siamo al di fuori del concorso esterno. In questo caso, infatti, non sussiste la necessità che l’extraneus si interessi dei fini dell’associazione, egli non deve tendere a rafforzare o fornire un qualsiasi apporto causale per la conservazione dell’associazione. Sono aspetti questi che, sebbene normalmente esistenti in una vicenda del genere, non entrano nella fattispecie penale e quindi non sarà richiesto al giudice di scrutinarne e verificarne la sussistenza.
In altri termini, si è di fronte ad una fattispecie in cui tra l’art. 416-ter c.p., concorso esterno (ex artt. 110 – 416-bis c.p.) e 416-bis c.p. c’è una progressione criminosa, con riguardo a tre vicende all’interno di uno stesso contesto con gradazioni di intensità differenti.
Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo la norma richiede un dolo generico.
Il dubbio, in particolare, è sul dolo eventuale.
Anche qui dobbiamo distinguere tra promittente e promissario. Il primo sicuramente non può agire con dolo eventuale, posto che egli è perfettamente consapevole di quello che sta facendo, cioè di essere un affiliato che ottiene delle utilità per procacciare voti con metodo mafioso.
Per quanto riguarda il promissario, invece, nella Relazione del Massimario della Corte di Cassazione, si stabilisce espressamente che appare estremamente improbabile che il promittente possa agire con dolo eventuale. Si desume, implicitamente, che con riguardo al promissario questa eventualità non sia del tutto impossibile.
Avv. Daniele Quaranta