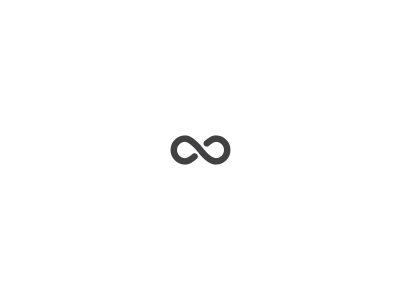L’elemento soggettivo del reato oggi è un requisito che ha assunto una rilevanza ed un’importanza decisiva nella strutturazione del reato.
Ormai c’è un’attenzione, forse esasperata, verso la delineazione di tale elemento che è presupposto fondamentale della colpevolezza.
La colpevolezza è un concetto molto “sfuggente” del diritto penale e la sua storia riflette tutte le sue tensioni di fondo.
È un concetto di per sé molto contrastato, così come sono molto contrastate le definizioni delle due nozioni di dolo e colpa.
La colpevolezza, altro non è che la rimproverabilità di un determinato comportamento: l’allontanamento, lo scostamento del soggetto dalla regola dettata dalla norma giuridica.
Questa definizione di rimproverabilità abbraccia tutti gli elementi soggettivi del reato, perché in tutti i casi c’è uno scostamento dalla regola di condotta.
Il principio di colpevolezza è divenuto principio irrinunciabile, in quanto si pone sia come vincolo per il legislatore – che non può più creare figure criminose svincolate da tale presupposto – sia come canone ermeneutico del giudice, che deve leggere e applicare le disposizioni vigenti in omaggio a tale principio.
Si discute, inoltre, se la colpevolezza presupponga l’imputabilità del soggetto (cioè sua la capacità di intendere e di volere), ovvero, quest’ultima sia requisito della prima.
Infatti, preoccupazione ricorrente del nostro sistema è quella di ricollegare sempre la sanzione penale ad un comportamento concretamente rimproverabile.
Il problema, però, è nell’applicazione concreta. Molto spesso, nonostante l’enunciazione dei principi generali, nell’applicazione concreta si giunge alla creazione delle c.d. colpa d’autore, ovverosia si immagina un elemento soggettivo che in realtà non esiste.
Si pensi ad esempio alla recidiva (circostanza aggravante per definizione ricollegabile ad una pregressa condotta del soggetto), all’ubriachezza abituale (che è, obiettivamente, un contestatissimo aspetto del diritto penale); nonché allo sfruttamento della prostituzione (anche se ad alcuni appare meno indicato come esempio di colpa d’autore).
Possiamo dire, quindi, che c’è sicuramente una chiara tendenza all’esaltazione dell’elemento soggettivo del reato ed un superamento di tutte le ipotesi che possono essere considerate in conflitto con il principio di colpevolezza o di offensività.
Non c’è più dubbio, inoltre, che assumano rilevanza tanto la personalità quanto gli stati d’animo del soggetto.
Altro elemento fondamentale che riguarda l’elemento soggettivo del reato è l’esigibilità.
Questo requisito imprescindibile (sempre fondamentale in particolare nella colpa), recentemente è stato oggetto di discussione, soprattutto in merito all’ammissibilità della esigibilità come causa generale di esclusione della colpevolezza, in particolare in relazione alla colpa.
È evidente infatti che tutte le imposizioni di un comportamento in concreto inesigibile, vanno espunte dal diritto penale.
Ebbene, intanto è possibile parlare di un comportamento rimproverabile, in quanto quel comportamento sia richiedibile al soggetto, cioè nella misura in cui il soggetto possa in concreto porre in essere quella determinata condotta.
Inoltre, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha inteso sottolineare che l’inesigibilità può anche essere intesa come causa generale di esclusione della colpevolezza. Il dubbio ancora oggi è quello inerente alla natura: ci si chiede se questa debba essere qualificata come causa di esclusione della colpevolezza o come evento fortuito che incide sul rapporto di causalità.
Questo dubbio denota tutta la connessione che c’è tra elemento soggettivo del reato e nesso di causalità, che appartiene invece all’elemento oggettivo della struttura del reato.
La colpevolezza deve poi essere compatibile anche con un altro aspetto, di matrice amministrativa, ossia con il principio di proporzionalità.
Ciò significa che la sanzione penale scatta in misura proporzionata al tipo di elemento soggettivo che viene in gioco.
Colpevolezza, quindi, significa anche punire un soggetto in misura proporzionata rispetto al rimprovero che gli può essere mosso.
IL DOLO:
Il dolo viene definito dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp del 2014 come la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza che esprime la più intensa adesione interiore al fatto.
Il dolo è coscienza e volontà in relazione al fatto storico.
La più autentica forma di volontà colpevole.
La Corte, nella citata sentenza, afferma altresì che le forme del dolo sono soltanto tre: intenzionale, diretto ed eventuale. Tutte le altre (alternativo, cumulativo, indeterminato, d’impeto, di premeditazione, specifico, etc.) sono delle mere modalità di realizzazione del dolo.
Con il dolo intenzionale il soggetto si rappresenta il fatto di reato e lo persegue intenzionalmente. Persegue intenzionalmente lo scopo finalistico della propria azione od omissione. Il dolo intenzionale si ha quindi quando il soggetto si rappresenta e persegue un determinato scopo, che coincide con l’evento (giuridico o naturalistico) che la norma penale mira ad evitare. Il risultato rappresentato, previsto e voluto, può essere certo, probabile o solo possibile. Ciò che conta è che la direzione della volontà sia verso quel risultato.
Mentre il dolo intenzionale è la figura classica ed autentica del diritto penale, il dolo diretto e il dolo eventuale rappresentano invece un’estensione del dolo.
Nel dolo diretto, infatti, già si inizia a intravedere la dominanza del momento rappresentativo. Mentre nel dolo intenzionale è pacifica la rilevanza del momento volitivo, nel dolo diretto rileva maggiormente il momento rappresentativo.
Il dolo diretto si ha quando la volontà non si dirige verso l’evento tipico (incriminato dalla norma), tuttavia l’agente si rappresenta come conseguenza certa o altamente probabile della propria azione tale risultato che però non persegue intenzionalmente.
Quindi la differenza chiara col dolo intenzionale risiede proprio nella non persecuzione intenzionale dell’evento tipico.
In altre parole, si è in presenza di una probabilità del verificarsi dell’evento talmente elevata da implicare la certezza soggettiva che l’evento si verificherà. Nel dolo diretto, pertanto, il soggetto si rappresenta una conseguenza accessoria della sua condotta, certa o altamente probabile, e ciononostante procede. Ecco perché nel dolo diretto predomina il momento rappresentativo.
Le Sezioni Unite del 2014 hanno stabilito che intanto si può parlare di dolo diretto in quanto vi sia un’alta probabilità di realizzazione dell’evento, in quanto l’accontentarsi di una mera possibilità comporta il rischio di spostare e di intaccare il confine che c’è tra dolo diretto e dolo eventuale.
La Corte, in altre parole, precisa che l’alta probabilità si sostanzia in una certezza soggettiva: il soggetto si rappresenta quell’evento e prevede, con certezza soggettiva, che esso si verificherà.
In altre parole si deve dimostrare che il soggetto fosse convinto che la sua condotta avrebbe realizzato quel determinato evento.
In un passaggio della suindicata sentenza la Corte si sofferma ad analizzare gli stati d’animo nel dolo diretto ed afferma che questo sussiste anche laddove il soggetto agisca con la certezza di realizzare il fatto tipico ma lo avversi tenacemente (ovverosia non vuole in cuor suo farlo produrre).
Ciò in quanto l’agente si è prospettato l’evento accessorio come certo e ciononostante ha agito, per tale motivo deve rispondere di dolo diretto.
Sempre a parere della Corte, qualora l’agente sia convinto, anche nel modo più alogico e colpevole possibile, di non cagionare l’evento, non si può mai parlare di dolo (diretto o eventuale). Anche in presenza di una previsione errata, colpevolmente errata, irragionevole, il dolo comunque non può sussistere, perché trattasi di figura soggettiva non a carattere normativo. Il dolo è una figura soggettiva reale, talché intanto sussiste in quanto il soggetto si rappresenta e vuole l’evento. Se il soggetto è convinto che l’evento non si verificherà, anche se questa convinzione è irragionevole, il dolo non sussite poiché dalla sua condotta non è desumibile la volontà dell’evento, che egli era convinto che non si verificasse.
Quindi dolo intenzionale e dolo diretto sono due figure di dolo, una dominata dal momento volitivo, l’altra da quello rappresentativo ma, mentre il dolo intenzionale è una figura meno problematica, al contrario, il dolo diretto desta sempre più dubbi. Ciò in quanto più ci si avvicina all’incertezza, più ci si avvicina alla colpa, più diventa difficile capire la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Corte, una volta esposto il dolo intenzionale e diretto, si sofferma anche sul dolo eventuale (dando così anche la risposta alla tematica del dolo generale) affermando che trattasi di istituto che nasce nella giurisprudenza per esigenze di garanzia. Si tratta di un istituto immaginato per segnare l’ultimo confine del dolo, al di là del quale si apre il territorio della colpa.
Poiché è figura di margine della fattispecie dolosa, il dolo eventuale consiste in un atteggiamento interiore che è in tutto assimilabile alla volizione dell’evento e per questo è rimproverabile a titolo di dolo, ma si configura in maniera molto particolare.
Si configura solo se l’agente si prospetta – con una rappresentazione lucida – la concreta e significativa possibilità di realizzazione dell’evento e ciononostante si determina ad agire, aderendo a quell’evento per il caso in cui si verificherà. Il dolo eventuale, in definitiva, designa l’area dell’imputazione soggettiva dai confini incerti, in cui l’evento accessorio non costituisce l’esito finalistico della condotta (non è dolo intenzionale), né costituisce conseguenza certa o altamente probabile (non è dolo diretto), ma rappresenta un possibile risultato di essa. La problematica del dolo eventuale racchiude nella sua struttura definitoria il confine tra dolo e colpa, e ancor più segna in molti casi il limite soggettivo dell’illecito penale.
Tradizionalmente il dolo eventuale ha dato vita ad una serie di ricostruzioni ermeneutiche, in particolare si sono contese il campo due ricostruzioni: una che ha dato spazio al momento rappresentativo e un’altra che ha dato spazio al momento volitivo.
Le teorie della rappresentazione o anche dette intellettive, danno rilevanza all’aspetto rappresentativo rispetto a quello volitivo. Sono teorie che nascono non per il dolo intenzionale, ma per far ricondurre nel dolo figure dubbie (dolo eventuale e diretto), figure in cui domina il momento rappresentativo.
Le teorie della rappresentazione vengono oggi contestate e lasciano il passo alle teorie volontaristiche. Tali teorie, senza mai negare rilievo alla rappresentazione, che resta elemento imprescindibile, danno grande rilievo all’aspetto centrale del dolo: la volontà.
La rappresentazione è fondamentale, ma il requisito sacramentale è la volontà.
La teoria rappresentativa e la teoria volitiva tra dolo eventuale e colpa cosciente:
Il dolo eventuale è il trionfo del momento rappresentativo. La teoria rappresentativa nasce per estendere le acquisizioni sul dolo intenzionale al dolo diretto e soprattutto al dolo eventuale. Secondo tale teoria può parlarsi di dolo eventuale nel momento in cui il soggetto si prospetta come possibile la realizzazione dell’evento e ciononostante agisce, accettando il rischio della sua verificazione.
La colpa cosciente, invece, viene tradizionalmente individuata nell’atteggiamento del soggetto che, pur prospettandosi la possibilità della verificazione dell’evento, si rappresenta questa possibilità come mera ipotesi astratta e agisce nella ragionevole speranza che l’evento non si verificherà.
Dolo eventuale e colpa cosciente si distinguono, quindi, già sul piano rappresentativo: mentre il dolo eventuale richiede la rappresentazione dell’evento e della sua possibile verificazione, la colpa cosciente è caratterizzata dalla mancata rappresentazione dell’evento. Nella colpa cosciente, infatti, il soggetto prevede la realizzazione dell’evento ma è convinto che questo non si realizzerà, in ciò si sostanzia la differenza. Secondo l’orientamento che è stato seguito per lungo tempo dalla maggioranza degli interpreti, difetta il momento rappresentativo. È una rappresentazione meramente astratta, perché il soggetto già sa che quell’evento non si realizzerà. Se invece un soggetto si rappresenta l’evento e lo valuta come possibile nella sua verificazione e ciononostante agisce, si può ritenere sussistente il dolo eventuale, perché se avesse voluto sottrarsi al rischio derivante dall’incedere della condotta, avrebbe dovuto arrestarla.
Se ha proseguito ha quindi acconsentito alla realizzazione dell’evento.
Secondo questa distinzione lo stato di dubbio non è in grado di escludere il dolo eventuale, perché se il soggetto si pone in dubbio sulla verificazione dell’evento e ciononostante agisce, senza risolvere il dubbio, accetta la possibile verificazione dell’evento e quindi è come se lo avesse voluto.
La colpa cosciente invece si caratterizza per l’esistenza di una previsione negativa: sorge lo stato di dubbio ma viene superato nel senso che l’evento non si verificherà, per abilità personali o altre circostanze.
Dalle critiche alla teoria rappresentativa del dolo eventuale è nata la teoria della volizione, che dà enorme rilievo alla dimensione volontaristica, nonostante il dolo eventuale sia, tra le tre forme di dolo, quello in cui il momento rappresentativo domina nel modo in assoluto più rilevante.
In particolare i critici della teoria rappresentativa sostenevano che non si può costruire la colpa cosciente o colpa con previsione come un elemento soggettivo in cui emerge una previsione negativa (o contro previsione). Infatti, se guardiamo il codice penale ci rendiamo conto che il legislatore esige, nella colpa cosciente, la previsione dell’evento, non la contro previsione.
In altri termini, la questione ruota attorno allo stato di dubbio.
Mentre nella ricostruzione rappresentativa lo stato di dubbio nella colpa con previsione è risolto in senso negativo e nel dolo eventuale resta irrisolto, in quanto il soggetto non sa se l’evento si verificherà, per la teoria volontaristica lo stato di dubbio deve essere risolto per potersi configurare il dolo eventuale.
Per parlare di elemento soggettivo doloso ci vuole la volontà e quindi è necessario che in presenza di uno stato di dubbio l’agente aderisca o meno all’evento da realizzare.
Lo stato di dubbio non esclude l’esistenza del dolo ma non è sufficiente ad integrarlo. Ci vuole qualcosa in più, ci vuole l’adesione di quel soggetto all’evento, altrimenti il dolo eventuale non è tale, perché si rischia di camuffare un’ipotesi di colpa con previsione.
La teoria volontaristica si realizza nella sua massima espressione con la teoria del cd. bilanciamento degli opposti interessi.
La teoria volontaristica del bilanciamento degli interessi ritiene che possa rispondere di dolo eventuale il soggetto che ha consapevolmente subordinato l’evento possibile (che si può realizzare) al perseguimento dei propri interessi. L’agente deve operare un consapevole bilanciamento tra gli opposti interessi e deve considerare l’evento accessorio e collaterale come possibile prezzo di un risultato desiderato. È quella che la Corte definisce la componente latu sensu economica del dolo eventuale. Il dolo eventuale è questo: una conseguenza accessoria e collaterale.
Collaterale perché il soggetto non vuole raggiungere quell’obiettivo, ne ha altri.
Accessorio perché è una possibilità, non è né certo né altamente probabile, quindi c’è effettivamente il dubbio sulla sua realizzazione, tuttavia, per perseguire il suo obiettivo accetta la possibile realizzazione dell’evento accessorio e collaterale, lo considera come il giusto prezzo da pagare e pertanto lo subordina al raggiungimento dei propri scopi.
La teoria dell’accettazione del rischio è stata portata sia a sostegno della teoria rappresentativa che della teoria volitiva.
Nella prima si sostiene che qualora l’agente versi in uno stato di dubbio e ciononostante agisca, si presume che abbia accettato il rischio della verificazione dell’evento. Non si guarda alla volontà, ma viene operata una mera valutazione oggettiva. Se l’agente ritiene possibile l’evento e ciononostante agisce anche a costo di provocarlo, vuol dire presuntivamente che ne ha accettato il rischio. Non si accerta in concreto l’accettazione e, quindi, la volontà.
In sostanza si trae dalla regola di possibilità una regola di colpevolezza.
Secondo la teoria della volizione, invece, l’accettazione del rischio si ha nei casi in cui il soggetto si prospetta l’evento accessorio e collaterale, versa in uno stato di dubbio ma questo viene superato mediante un bilanciamento degli interessi. In tal modo si accerta in concreto che il soggetto sostanzialmente l’ha voluto, perché ha subordinato quell’evento accessorio al perseguimento dei suoi scopi. In questo caso si parla di accettazione del rischio come componente volitiva e non rappresentativa.
La vera differenza è che nella prima (teoria rappresentativa) l’accettazione del rischio è una valutazione presuntiva derivante da una regola di possibilità, nella teoria volitiva invece l’accettazione del rischio è un modo per dire che in concreto il soggetto ha superato il dubbio, accettando il rischio, mediante un bilanciamento e pertanto ha voluto l’evento accessorio.
La teoria rappresentativa ha un grande merito: semplifica l’accertamento, standardizza le valutazioni, le condizioni, le indagini probatorie. È una valutazione quasi normativa, quasi oggettivizzata. Si desume da una condotta posta in essere la presunzione di volontà. È un giudizio oggettivo, standardizzato. Sarà identico per tutti coloro che si rappresentino l’evento accessorio collaterale e ciononostante agiscano. È una regola che normalmente non dà grande rilievo agli atteggiamenti interiori, quindi è un giudizio molto più facile da operare.
La teoria volitiva invece ha il merito di essere perfettamente in linea con la parabola evolutiva dell’elemento soggettivo, che, appunto, esalta l’aspetto volitivo. Tuttavia, anche questa teoria presta il fianco a due critiche: comporta grandi difficoltà probatorie e dà rilevanza degli stati d’animo.
Già prima delle Sezioni Unite del 2014, la giurisprudenza di legittimità aveva aderito alla teoria volitiva, evidenziando che, pur presentando entrambe pro e contro, il vero difetto della teoria rappresentativa risiede nella presunzione di sussistenza della volontà: è un difetto che non può essere colmato. La teoria rappresentativa del dolo eventuale immagina un atteggiamento interiore che assume un volto astratto (si guarda in astratto ed è uguale per tutti), oggettivizzato, presuntivo che vulnera il principio di colpevolezza. In altri termini la teoria rappresentativa è una teoria illegittima, perché non dà conto del modo di essere del dolo.
Al contrario, ammette la Corte, seguendo la contrapposta ricostruzione fondata sulla volizione, si corre comunque il pericolo di far dipendere l’essere o il non essere del reato dai concreti moti emotivi del soggetto.
Dolo eventuale e colpa cosciente nella sentenza delle Sez. Unite del 2014 THYSSENKRUPP:
La Corte di Cassazione, per cercare di ovviare agli inconvenienti sopra indicati, nella notissima sentenza a Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp del 2014, ha dato precise coordinate sulla sussistenza e differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Secondo le Sezioni Unite la distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione è una distinzione complessa in quanto è sempre stata complessa ed oscura la figura del dolo eventuale.
Complessa ed oscura perché il momento rappresentativo riguarda un evento il cui coefficiente probabilistico non è tanto significativo da risolvere lo stadio di dubbio.
Tale affermazione incentra in sé tutta la differenza con il dolo diretto, dove invece il coefficiente probabilistico è tanto elevato da risolvere l’eventuale stadio di dubbio.
Spesso si è sostenuto in giurisprudenza e in dottrina che il dolo eventuale e colpa con previsione fossero caratterizzati da un labile tratto di confine.
In realtà, spiega la Corte, dolo eventuale e colpa cosciente appartengono a due distinti universi, non presentano alcun punto di contatto e sono diversi in tutto e per tutto.
La previsione, presente sia nel dolo che nella colpa, è completamente diversa, così come diverso è l’evento, l’agire umano e l’animus. Non è dunque possibile qualificare come dolo eventuale ipotesi che appartengono al mondo della colpa.
La Corte, inoltre, prende posizione anche su un’altra antica questione: se la colpa con previsione possa essere intesa come colpa in cui esiste una previsione negativa o una controprevisione. Secondo la Cassazione è necessario superare questa ricostruzione e deve ritenersi che nella colpa con previsione debba esserci una reale previsione dell’evento.
Il diritto penale è piegato ai principi di tassatività, determinatezza, legalità e il legislatore non fa nessun cenno alla controprevisione né ad una previsione negativa. La previsione è positiva e concreta. Richiedere una controprevisione significa immaginare un soggetto irreale che agisce con un comportamento colposo e che lucidamente analizza i vari eventi.
Sostenere che il dolo eventuale si ha nei casi in cui nel soggetto sorge il dubbio e questi va avanti senza arrestare la sua condotta, vuol dire sostanzialmente dar vita ad una sorta di presunzione, perché la valutazione sull’accettazione dell’evento accessorio non nasce da un’indagine concreta sulla volontà, ma da una valutazione aderente ad una condotta oggettivizzata: non c’è nessuna indagine concreta, si è di fronte ad una presunzione di colpevolezza che nel diritto penale non può essere ammessa.
Il dolo è caratterizzato dalla puntuale e chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico. Tanto è vero che l’art. 43 c.p. è reputata norma che, da un lato, dimostra che il legislatore ha accolto la teoria volitiva, dall’altro, è incompleta perché fa riferimento solo all’evento e non a tutto il fatto storico. Pertanto, anche il dolo eventuale deve esprimersi in una chiara conoscenza di tutti i fatti.
La possibilità di verificazione dell’evento, inoltre, deve possedere un sufficiente grado di probabilità poiché, se il grado di probabilità di verificazione dell’evento è trascurabile, sarà quasi impossibile, salvo prove concrete, immaginare una relazione di adesione interiore. Nel dolo eventuale, quindi, non c’è certezza né alta probabilità, ma solo una possibilità di verificazione dell’evento che, però, deve essere caratterizzato per un apprezzabile livello di verificazione.
Nel dolo eventuale, come nel dolo in generale, la previsione è diversa rispetto alla colpa con previsione, come è diversa rispetto alla colpa in generale: nel dolo eventuale e nel dolo in generale la rappresentazione è chiara, lucida e concreta. Nella colpa, invece, si è di fronte ad una rappresentazione che è diversa: è sempre stata opaca, umbratile, fatta più di pieni che di vuoti, caratterizzata immancabilmente, al fondo, da qualcosa che è mancato, bisognosa di eterointegrazione.Siamo di fronte ad un concetto nebuloso.
Nella colpa in generale e nella colpa con previsione la previsione dell’evento è ben più vaga e alquanto sfumata rispetto al dolo eventuale. Del resto, ciò che manca alla colpa e che, invece, è presente nel dolo e, quindi, anche nel dolo eventuale, è l’essenziale relazione tra volontà e causazione dell’evento, il nucleo sacramentale del dolo. Le differenze clamorose tra dolo e colpa si ripercuotono necessariamente anche tra dolo eventuale e colpa cosciente.
In questa distinzione chiara, almeno in astratto, si pone la questione degli stati d’animo.
In riferimento agli atteggiamenti della sfera emotiva (ottimismo, pessimismo, la speranza di verificazione di un evento) assistiamo ad un cambiamento di rotta della giurisprudenza che, dall’affermarne la totale assenza di ruolo nella valutazione circa la sussistenza del dolo e della colpa, con la sentenza a Sezioni Unite del 2014 arriva ad affermazioni di segno opposto. Infatti, sostiene la Corte, affinché possa ritenersi sussistente il dolo eventuale è necessario dimostrare in concreto una consapevole presa di posizione di adesione all’evento: la volontà.
Tuttavia, trattasi di una volontà indiretta, per analogia o per equivalente, ovvero non lucida.
È possibile condannare per dolo eventuale soltanto se c’è una prova certa che il soggetto volesse l’evento, senza la prova dell’adesione non vi può essere dolo eventuale. Pertanto, se lo stato di dubbio è irrisolto non c’è dolo eventuale. Questo è il senso della sentenza: c’è dolo eventuale quando lo stato di dubbio è risolto nel senso dell’adesione all’evento.
Tra le tre forme di dolo, quello eventuale è certamente quello che presenta un l’elemento volontaristico più attenuato, ma questo è comunque presente e deve essere valutato e dimostrato in concreto.
La vera differenza tra dolo eventuale, dolo diretto e dolo intenzionale, pertanto, risiede nel diverso atteggiarsi della volontà, che qui è una volontà indiretta o per analogia che si desume dal fatto che il soggetto pone in essere una condotta volendo raggiungere un altro obiettivo.
Si parla di volontà indiretta in quanto il coefficiente volontaristico è desunto dal grado di probabilità di verificazione dell’evento. Il confine tra dolo diretto e dolo eventuale sta nel grado di probabilità di verificazione dell’evento accessorio. Tuttavia, non si può ritenere sussistente la volontà desumendola dal grado di probabilità.
Se si è in presenza della probabilità di verificazione dell’evento allora si ha un ottimo indizio ma devono essere utilizzati ulteriori strumenti per comprendere se in concreto vi sia stata l’adesione da parte del soggetto.
Nella sentenza sul caso Thyssenkrupp la Corte afferma quindi che la sussistenza del dolo eventuale va accertata in via indiziaria, come del resto normalmente accade quando si tratta di indagare sugli atteggiamenti interiori ed individua una serie di elementi indiziari.
Non si pongono particolari problemi con riferimento ai delitti di sangue, in cui normalmente la direzione della volontà si guarda partendo dalla modalità della condotta (tipo di arma, la direzione dell’arma, la vicinanza dell’arma al corpo, la parte del corpo attinta e via dicendo). Sono tutti criteri che nei delitti di sangue danno il senso del dolo o della colpa. Sono i criteri più scontati che normalmente non destano grandi problemi.
I problemi nascono con riguardo agli altri indici indiziari che la Corte immagina per verificare la sussistenza del dolo eventuale.
Di seguito gli elementi indiziari enunciati dalla Corte:
1) Lontananza della condotta posta in essere dagli standard di condotte evidenziate dalle norme penali.: quanto più grave ed estremo è lo scostamento dalle regole di condotta tanto più si apre la strada ad una cauta considerazione della prospettiva dolosa.
2) La personalità, la storia le esperienze precedenti del soggetto: la personalità può disvelare le caratteristiche dell’agente, la sua cultura, l’intelligenza del soggetto, la conoscenza del reale contesto in cui i fatti sono maturati.
3) Durata e ripetizione della condotta: un comportamento repentino, impulsivo dà l’idea di un comportamento colposo. Una condotta lungamente studiata, protratta nel tempo dà l’idea di un comportamento doloso.
4) Condotta successiva al fatto: se c’è una fattiva e spontanea opera di soccorso, probabilmente siamo di fronte ad un comportamento colposo, perché non c’è volontà del fatto; se, invece, c’è un tentativo di fuga o comunque un comportamento non consono si apre la strada ad una valutazione dolosa.
5) Fine della condotta e sue motivazioni: verificare il fine della condotta e le motivazioni di questa e rapportarle alle conseguenze collaterali della condotta stessa. Prendere l’evento accessorio e verificare se quelle finalità e quelle motivazioni danno vita ad una condotta che può essere considerata ragionevole. Questa è la teoria del bilanciamento di interessi perché in sostanza bisogna indagare se l’evento accessorio perseguito rappresenti il giusto prezzo (prezzo congruo, dice la Corte) da pagare per l’obiettivo finale preso di mira.
6) Grado di probabilità di verificazione dell’evento: più è probabile la verificazione dell’evento più si propende verso il dolo eventuale, meno probabile è l’evento più ci si avvicina ad una colpa con previsione. Naturalmente la probabilità non deve mai entrare nella certezza o nell’alta probabilità perché altrimenti si sposta il confine con il dolo diretto.
7) Le conseguenze negative o lesive per l’agente della condotta posta in essere
8) Contesto lecito o illecito della condotta: la colpa è compatibile con un’attività a base lecita, il dolo con un’attività a base illecita. Una situazione illecita di base fa propendere per il dolo. La colpa normalmente si sviluppa in un contesto lecito.
9) Il giudizio controfattuale della prima formula di Frank: si ritiene sussistente il dolo eventuale, e il dolo in generale, riconducendo virtualmente l’atteggiamento dell’agente alla categoria del dolo diretto. Si è in presenza di un giudizio ipotetico (giudizio controfattuale) in cui si valuta cosa sarebbe accaduto se l’agente avesse avuto certezza della verificazione dell’evento. Se la risposta è che l’agente avrebbe perseguito quella condotta c’è dolo eventuale ed è rispetta la prima formula di Frank. Altrimenti, secondo alcuni, non c’è dolo eventuale, ma colpa cosciente.
Secondo la Corte la prima formula di Frank può essere un criterio risolutivo: se applicata con esito positivo vi è sempre dolo, ma, se non si riesce a formulare questa indagine allora il dolo non si può escludere. La formula di Frank è un criterio fondamentale, ma mostra comunque un grande limite che è quello di trattare il dolo eventuale come dolo diretto.
10) Gli stati d’animo, gli stati affettivi, emozionali, ottimismo, pessimismo: come visto in precedenza, a parere della Corte anche gli stati d’animo possono incidere nell’accertamento del dolo eventuale.
10) Principio del favor rei: nel dubbio si applica l’ipotesi meno grave rappresentata dalla colpa con previsione.
LA COLPA:
La colpa, rispetto al dolo, non è una forma originaria e generale di colpevolezza. Non è originaria perché è una forma di tardiva acquisizione e non è generale perché ammessa solo nelle ipotesi previste dal legislatore. La Corte di Cassazione ha affermato che la colpa “si compone di un elemento oggettivo, impersonale, normativo e di due elementi soggettivi”:mancanza di volontà e capacità del soggetto di osservare la regola.
“L’aspetto oggettivo, invece, rappresentato dalla regola cautelare di riferimento, ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l’esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale”.
Che la colpa sia un concetto molto complesso e nebuloso emerge anche dal fatto che il requisito soggettivo (mancanza di volontà) va distinto nei reati di mera condotta e di evento. La mancanza di volontà nei reati di evento, si sostanzia in mancanza di volontà nella realizzazione dell’evento, mentre la condotta può essere invece voluta.
Nei reati di mera condotta, invece, la mancanza di volontà attiene all’azione posta di essere dal soggetto agente.
La colpa si sostanzia nella violazione di una regola cautelare, nella mancanza di volontà e capacità di osservare il precetto, il tutto affasciato da prevedibilità ed evitabilità che sono all’origine della regola cautelare.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è scatenato in riferimento al significato di violazione di una regola cautelare. La Corte di Cassazione è stata chiarissima su questo aspetto, affermando che per violazione di regola cautelare si deve intendere l’inosservanza delle regole di condotta dirette a prevenire quei determinati eventi dannosi concretamente verificatesi. Il grande problema della norma cautelare è rispettare il principio di legalità, tassatività e determinatezza in relazione alla colpa. Pertanto, la violazione della regola cautelare non può consistere mai in una generica obbligazione di diligenza ma intanto si può parlare di colpa in quanto si guardi a una colpa in concreto (Sezioni Unite 2009/22676).
In particolare ciò accade quando il soggetto pone in essere un evento dannoso che la regola cautelare mirava a neutralizzare.
La violazione della regola cautelare pone un problema di compatibilità con i principi di legalità, tassatività e determinatezza perché è una regola che deve essere necessariamente etero integrata all’esterno.
Tuttavia non basta la violazione della regola cautelare ma, a parere della Corte, occorre operare una distinzione tra norme elastiche e rigide: le norme rigide sono quelle norme la cui violazione comporta normalmente l’addebito di colpa (ma sono rare); quelle elastiche richiedono un accertamento in concreto; vale a dire che dopo la violazione della regola cautelare è necessario valutare l’attribuibilità di quella condotta all’agente, quindi la rimproverabilità della condotta, in quanto la mera violazione di una regola cautelare non è di per sé dirimente.
Per capire se un evento è attribuibile all’agente, pertanto, bisogna valutare la rimproverabilità che fondamentalmente deve tenere conto sia della prevedibilità sia dell’evitabilità. Ciò in quanto si può violare la regola cautelare in via oggettiva ma se manca quella che la Corte ha definito la “componente squisitamente soggettiva” ovverosia la possibilità di rispettare quella regola, naturalmente la colpa non è configurabile.
La prevedibilità non va accertata solo in relazione all’evento finale ma va accertata in relazione a tutti i fatti ed in particolare anche con riguardo al decorso causale. Nello specifico la prevedibilità deve attenere al decorso causale nelle sue linee essenziali.
Si deve verificare se quel decorso causale è stato preso in considerazione dalla regola violata: bisogna analizzare, dunque, i più significativi anelli della catena causale, capire se quel decorso causale rientra in quelli immaginati dalla regola violata e confrontarlo con il comportamento dell’agente.
Il giudizio sulla colpa dell’agente passa attraverso una valutazione che viene definita: la causalità della colpa.
Infatti, per capire se l’evento realizzato era evitabile, spesso si opera una sovrapposizione con le indagini in termini di causalità.
Tale sovrapposizione dovrebbe invece essere evitata in quanto si è di fronte a due istituti (rapporto di causalità e causalità della colpa) ispirati da regole differenti e, quindi, è necessario tenerli separati. La causalità, infatti, si ispira alla ragionevole certezza che quella condotta ha causato quell’evento, mentre l’evitabilità non si ispira alla certezza bensì alla possibilità.
Per capire se il soggetto può essere imputato di una responsabilità colposa, pertanto, bisogna effettuare il giudizio di prognosi postuma collocandosi in una prospettiva ex ante rispetto alla verificazione dei fatti e fare un prognostico sulla prevedibilità e evitabilità dell’evento. Si tenga conto che invece il giudizio di causalità è normalmente un giudizio ex post.
Per effettuare un giudizio di prognosi postuma si deve capire a quali elementi dare rilievo e a quali no. Normalmente si tende a guardare all’homo eiusdem condicionis et professionis (agente modello) anche se, operare un giudizio solo in base a tale elemento, comporta il rischio di oggettivizzare troppo il giudizio della colpa.
Infatti, poiché la colpa deve sostanziarsi in una colpa in concreto appare più appropriato guardare sia alla regola cautelaresia a tutte le circostanze del caso concreto.
Ciò che è fondamentale è che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi provocati ma solo a quelli che sono derivati dalla violazione di quella norma a condizione che la stessa tendesse a evitare eventi del tipo di quelli realizzati. Quindi non tutti gli eventi, ma solo quelli sussumibili sotto a quelli che la regola cautelare voleva evitare.
La causalità della colpa sussiste, invece, quando è possibile immaginare il cd. comportamento alternativo lecito.
Ma a parere della Corte, non bisogna confondere il profilo causalistico oggettivo con il profilo causale della colpa che ha invece matrice soggettiva.
Da questa distinzione appena delineata si comprende perché questi due elementi soggettivi si atteggiano in maniera diversa nel sistema penale.
Non è un caso che nel delitto tentato è solo il dolo la figura prevista dal legislatore ed in particolare non tutte le forme di dolo.
Molto più importante è capire l’elemento soggettivo alla luce di questa distinzione nei fenomeni di compartecipazione nel reato.
Nei reati plurisoggettivi, l’elemento soggettivo si sostanzia sempre in dolo o colpa ma inizia a cambiare la sua struttura.
Infatti non si guarda più alla realizzazione dell’evento, bensì alla connotazione di agevolazione dello stesso.
Quindi l’elemento soggettivo non deve tendere a provocare l’evento ma a renderlo più agevole nella realizzazione, poiché l’art. 110 c.p. ha la funzione di estendere la tipizzazione a fatti che in ipotesi non sono punibili.
La grande novità, però, riguarda la cooperazione colposa. La stessa definizione che ne da il legislatore ne dimostra la peculiarità: “nel delitto colposo quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.
Siamo di fronte ad una definizione talmente precaria e generica da mettere in dubbio la sua compatibilità con i principi di tassatività e determinatezza e tali caratteristiche ne rendono anche difficile la delineazione.
Risulta pertanto necessario affrontare la differenza tra cooperazione colposa e concorso di cause indipendenti.
Nel concorso di cause indipendenti le varie cause che viaggiano verso l’evento non hanno quello che la giurisprudenza ha definito “il collante” che lega l’elemento soggettivo dei compartecipanti. Nella cooperazione colposa, pur non essendoci ovviamente una volontà (poiché si tratta di colpa), c’è comunque un collante che unisce le varie condotte dei cooperanti.
L’eterno dubbio dell’interprete è individuare il collante che unisce le diverse condotte. Il collante è tradizionalmente di natura psicologica: sussiste se c’è la consapevolezza da parte del soggetto di accedere a un’altrui condotta colposa.
A parere della Corte però questo collante psicologico viene spesso enfatizzato e sopravvalutato in quanto, richiedere la consapevolezza del carattere colposo della condotta a cui si accede svuota la cooperazione colposa rendendola poco utile.
Se il soggetto che accede alla condotta di colui che agisce con comportamento colposo sa già di accedere a tale condotta, questi generalmente è autonomamente punibile quindi l’art. 113 c.p.
L’art. 113 c.p. impone a tutti i soggetti che partecipano a questo intreccio cooperativo di verificare e di soppesare l’operato degli altri soggetti: ciascuno deve rapportarsi a un altro soggetto, deve preoccuparsi anche delle condotte tenute dagli altri e delle eventuali conseguenze.
Siamo di fronte ad un principio derogatorio del sistema perché normalmente vige il principio di auto-responsabilità secondo il quale ognuno è responsabile della propria condotta e non di quella di altri soggetti.
ELEMENTO SOGGETTIVO E PERSONA GIURIDICA:
Quando di parla di elemento soggettivo, il connotato forse più peculiare si ha con riguardo alla persona giuridica, soggetto etereo e astratto.
A parere della giurisprudenza la responsabilità delle persone giuridiche, fotografata dal D.lgs. 231/200,1 non è né una responsabilità amministrativa, né una responsabilità penale. La Corte aderisce alla teoria del tertium genus: una figura che coniuga nello stesso tempo momenti di responsabilità amministrativa e momenti di responsabilità penale. Si sostanzia in un sistema chiaramente preventivo con aspetti penali legati alle forti garanzie per l’imputato.
Non si tratta di una responsabilità in deroga ai principi generali poiché si risponde per fatto proprio e non per fatto altrui, esistendo un rapporto di immedesimazione organica che lega il soggetto che agisce all’ente.
L’elemento soggettivo per le persone giuridiche è sensibilmente diverso rispetto alle persone fisiche in quanto si è di fronte ad un’organizzazione complessa. Per tale motivo, si parla della cd. colpa da organizzazione, che è un altro modo di essere dell’elemento soggettivo. Ci troviamo davanti a un concetto che non ha carattere squisitamente soggettivo ma normativo: non ha nulla di soggettivo pur attenendo all’elemento soggettivo del reato. La colpa da organizzazione come elemento soggettivo nella responsabilità delle persone giuridiche ha un connotato normativo: sussiste quando l’ente non ha adottato le cautele necessarie per impedire il reato. La colpa da organizzazione va guardata in senso oggettivo: consiste nel non aver predisposto la documentazione di attestazione dei rischi per prevenire i reati dello stesso genere di quello concretamente verificatosi. Siamo quindi davanti a un elemento soggettivo completamente sui generis.
C’è un ulteriore passaggio da fare con riguardo ai reati colposi, poiché tra i presupposti per la configurabilità della responsabilità della persona giuridica c’è anche la necessità della commissione di determinati reati tassativamente indicati dal legislatore. Normalmente sono reati dolosi, ma il legislatore ha previsto con le ultime novelle anche alcuni reati colposi. E si pone il quesito poiché la responsabilità della persona giuridica (scaturente dalla condotta dell’amministratore) è legata ai requisiti dell’interesse e del vantaggio dell’ente.
Ci si chiede pertanto come sia compatibile la commissione di un reato colposo con la circostanza che il reato debba essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Per i reati dolosi è chiaro che c’è la volontà; ma nei reati colposi la volontà manca.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sostenuto che i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi di evento devono essere ricondotti non all’evento ma alla condotta. In particolare deve essere fatta una distinzione: se il reato è di evento la mancanza di volontà è in relazione all’evento, mentre se il reato è di mera condotta la mancanza di volontà è in relazione alla condotta. Dunque, nei reati di evento, per il vantaggio o l’interesse si guarda alla condotta, che è volontaria.
Avv. Daniele Quaranta